Il rinfresco barocco del cardinale Flavio Chigi, tra meraviglia ed artificio
La Roma barocca dei conviti non aveva niente da invidiare allo sfarzo e alla magnificenza della corte estense e gonzaghesca. Opulenza ed uno spiccato senso artistico degli allestimenti erano i protagonisti assoluti dei numerosi banchetti che si susseguivano senza sosta negli ambienti ecclesiastici cittadini.
Di particolare interesse fu il rinfresco che il cardinale Flavio Chigi, nipote di papa Alessandro VII (1665-1667), organizzò il 15 agosto 1668 nei sontuosi giardini della sua villa situata nei pressi delle Quattro Fontane, vicino alla basilica di Santa Maria Maggiore. In quel contesto vennero serviti agli astanti unicamente canditi, dolci, bibite e sorbetti.
L’occasione era particolarmente allettante anche per gli ospiti poiché l’anfitrione predispose il tutto in onore dei principi Rospigliosi, parenti di Papa Clemente IX, al secolo Giulio Rospigliosi, salito al soglio pontificio il 26 giugno 1667. Una corposa e puntigliosa rendicontazione dello strabiliante evento è sondabile nella Risposta del signor Carlo Fontana alla lettera dell'illustriss. sig. Ottauio Castiglioni dell’architetto e scultore Carlo Fontana (1638-1714), allievo del Bernini, assoldato dal Chigi per quella occasione in veste di progettista e realizzatore degli allestimenti.
Il trionfo dell’effimero, un teatro all’ennesima potenza ed una quasi surreale rappresentazione del potere, insomma. Ciò ci aiuta anche a comprendere gli aspetti di ordine antropologico e sociologico sottesi alla pomposità tipica dei banchetti romani del periodo preso in esame.
Il rinfresco ebbe inizio verso mezzanotte. Già molte ore prima un discreto numero di macchine ed elementi scenici di varia natura era stato predisposto un poco ovunque nei giardini, pronto ad essere sottoposto a mirabolanti metamorfosi fra lo stupore generale dei presenti. Fontana, tra l’altro, arricchisce il suo racconto accompagnandolo con splendide planimetrie e disegni riproducenti le scene, i trionfi, le tavole e le credenze di mostra.
Il rinfresco si aprì con il rito dell’accoglienza, una sorta di prologo dell’evento principale durante il quale l’ospitante riceveva in pompa magna i convitati. Il cardinale Chigi accompagnò i nobili astanti verso il Boschetto attraverso un maestoso viale alberato posto in salita, lasciandosi alle spalle «l’ingresso che si rialza pieno di fontane e di calate d’acqua». Nel percorso furono allestiti «due palchi uno per i Musici, e l’altro per i Gentilhuomini tutti coperti di verdure».
Una serie di gradini circolari conduceva al Boschetto, una struttura rialzata dalla quale sgorgava un capo d’acqua, «che cadendo da una grand’altezza sopra certe pietre arteficiosamente disposte, spumosa si rompe». Gli ospiti si ritrovarono quindi all’interno di un luogo delimitato da «muraglioni tutti coperti di verdura».
Ed ecco quindi prendere letteralmente il via una inaspettata pièce teatrale: uno stranito e malconcio giardiniere, tal Ciarmaglia, spunta dal nulla e finge di stupirsi della presenza di così nobili ospiti. Nel mentre che si appresta ad apparecchiare una tavola compaiono tre divinità con i loro vestiti colorati e sgargianti: Flora, Pamona e Bacco sono pronti ad aiutare il povero Ciarmaglia. Ma i cibi offerti - prosciutto, salame e formaggio - secondo Bacco risultano eccessivamente rustici per tali nobili palati. Il dio del vino si infuria per la modesta e banale accoglienza, inveisce contro il giardiniere e getta con veemenza la tavola apparecchiata verso i sassi della fontana posti in basso.
Contemporaneamente al frastuono prodotto il geniale Fontana aziona un meccanismo lì vicino che fa innalzare tre strutture che disvelano «dal fianco verso Levante una superba bottiglieria, dall’altra verso Ponente una quasi incantata credenza, e tra l’una e l’altra situata verso mezzogiorno la fontana». L’opulenta credenza di mostra, quintessenza della “cucina politica”, faceva bella mostra di sé con i suoi appariscenti sette ripiani, ognuno allestito con candelieri argentei. Gli scalini, impreziositi con del tessuto broccato, erano percorsi da liste di gemme di lapislazzuli, ospitavano lini abilmente piegati in mille fogge, piatti, brocche d’oro e d’argento e vasi preziosi. Due strutture piramidali sporgevano dai lati, ai loro angoli erano collocati bacili, piatti e vasi d’oro le quali «bocche mandavano fuori una stella di cambrai inamidata, che risaltava sopra in diverse foggie di piegature ottagonali».
Le sommità sorreggevano due enormi vasi colmi di verdure e fiori. Nel mezzo della credenza di mostra era allocato un vistoso arco ornato con «un festone di piegature», cioè un telo artistico che lasciava intravedere un altro arco in prospettiva realizzato con verdure e «lumeggiato di talchi, di specchi e d’argento».
Al di sotto di ciò trovava posto la maestosa “tavola grande” che ospitava, tra i vari orpelli, alcuni trionfi e macchine di ghiaccio realizzati da Girolamo Mei «credenziere pratichissimo che per lo spatio di quattordici anni nella corte del signor Cardinale Chigi si era esercitato in simili lavori». Di fronte alla credenza era stata predisposta l’altrettanto sontuosa bottiglieria che presentava numerosi cristalli di varia fattura disposti su più ripiani. Il primo «reggeva brocconi d’argento e fanaloni listati d’oro distinti da lumi, da fiori, e da verdure». In questa struttura si potevano notare anche «organetti, fontane, ghiacciare, sottocoppe, bacili, Tazzoli, giaroni, brocchette, concoline» e chi più ne ha più ne metta!
Dopo essere stati sedotti da cotanto splendore, i convitati volsero lo sguardo verso l’incantevole fontana ed esplosero in un fragoroso applauso. Lungo il perimetro della stessa, a pelo d’acqua, erano stati adagiati dei piccoli contenitori argentei che ospitavano dei candelotti alternati a zampilli. Un affascinante gioco di luci rapì l’attenzione: «ribattendo il lume nel teatretto della medesima adorno di grotteschi lumeggianti d’oro d’azzurro, e di altre pietre pretiose, illuminavano anche per riflesso tutto il circuito».
Nel mezzo della fontana un gigantesco concone argenteo accoglieva ai lati due cornucopie che versavano acqua al suo interno. L’acqua precipitava quindi nella «vasca maggiore, il labro de la quale era tutto dorato, e l’estremità toccante il terreno finta con gli sbruffi di granatiglia; di fuori era adornata la facciata con infinite conchiglie d’argento, e ricca di lapislazzuli, di granatiglie d’oro: le parti laterali s'abbellivano con spalliere di agrumi veri».
Il magnifico rinfresco del cardinale Flavio Chigi era ben lungi dal terminare...


-Banquet-of-Grand-Duke-Ferdinand-I-of-Tuscany-c1590-oil-on-canvas-Kunsthistorisches-Museum-Vienna.jpg)
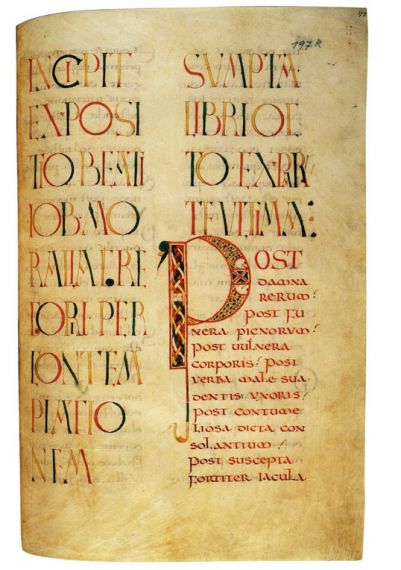
Commenti
Posta un commento